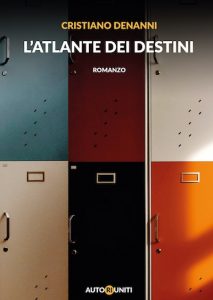Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale.
“‘Ho scoperto che la consapevolezza di stare per morire ti distoglie, chissà se per la prima volta, dall’abitudine a pensare che la vita sia né più nè meno che un vizio. Io per tutta la vita ho insegnato, i ragazzi sono stati il mio teatro, storia e geografia del più dei miei anni, e ora, a diciannove mesi dalla pensione, ho salutato tutti e mi sono messo sulle tracce del primo dei miei desideri di ragazzo: l’Asia del fiume Indo. I medici mi avevano dato alcune settimane di vita, il cancro penso fosse d’accordo con loro, ma per quanto riguardava me, avevo altri programmi. Così ora sono qua, a Karachi, dove scrivo, appena rientrato dalla catena del Karakorum, nel Kashmir. Anzitempo, rispetto a quanto previsto. Nel frattempo sono scampato alla prima condanna, perché è da oltre sei mesi che questo fiume distrae la mia esistenza, per la precisione centonovantasette giorni, e della morte, a oggi, manco l’ombra. Fanculo!
“La mia non è una vicenda chissà quanto particolare. E’ quella di un uomo che da ragazzo aveva un sogno, non l’ha mai realizzato, e prima di morire s’accorge d’essere stato un coglione. Tutto lì. Ma c’è qualcosa di più importante.
“Insegnavo lettere e filosofia in una scuola superiore della bellissima Salamanca, la mia città natale, dove ho fatto e subìto il più delle cose che ho fatto e subìto nella mia vita, eppure quel posto, da qui, non mi manca. Non mi mancano la scuola e l’insegnamento, ma i ragazzi tanto, loro sono il legame con la vita, che quando non ci sarà più mi immalinconirà.
“Fin da bambino sognavo l’Indo, questo angolo non indifferente di mondo, su per giù dall’età di undici anni. Non che non abbia viaggiato, in tutti questi anni, da solo o in compagnia. Ho girato l’Europa e ho visto qualcosa degli Stati Uniti e qualche paese sudamericano, ma alla fine questo desiderio era sempre rimasto agganciato al fondo di un cassetto, abbiamo tutti presente quando si aspetta l’occasione buona per fare qualcosa, facendo finta che non lo sia ancora, che non ci siano tempo oppure modo oppure soldi oppure la compagnia o la solitudine adatte ecc… Solo che l’occasione buona è quella che abbiamo davanti agli occhi, tutto lì. Mi son dovuto sentir dire che ho un grumo di cellule impazzite che si ammonticchiano in gola per capire che ho sempre chiesto in prestito, quando in realtà avevo molto più di ciò che elemosinavo. Sì insomma, alla fine è una semplice questione di scelte, la possibilità l’abbiamo davanti, ma preferiamo volgere lo sguardo altrove.
“Prima di andarmene in Asia, però, avevo bisogno di fare una cosa, parlare ai ragazzi. Non solo perché gli dovevo una spiegazione, ma perché avevo bisogno di loro, del loro aiuto.
“Così lo feci. E una mattina portai a scuola il mio solito taccuino, che normalmente utilizzavo per segnare appunti sulle lezioni, ma che quel giorno usai come una sorta di registratore.
“Raccontai loro della diagnosi, quindi del mio desiderio, che stavo per trasformare in realtà. Non appena terminai, cominciò uno scambio che non dimenticherò mai. Quando tornai a casa ero profondamente turbato ma ero anche felice. E’ difficile da spiegare… Sentii la necessità di appuntare tutto quello che ci eravamo detti, in parte facendolo già in classe, in parte al tavolo del mio soggiorno. Considero quei dialoghi il mio avere più grande. Parlammo della paura, della mia e delle loro. Dei desideri o delle piccole soddisfazioni che avrei voluto togliermi. Di pentimenti e sospesi. Di mio padre e di mia madre, d’amore, sentimenti, sconfitte. Della complessità e della meraviglia di ogni età che attraversiamo. Fra gli altri, ricordo Ines, che mi chiese “E adesso come facciamo, professore?”, le risposi che sarebbe subentrato un supplente che in fin dei conti conoscevano già, ma in mezzo a un silenzio pasticciato qualcuno controbattè “forse Ines non voleva dire questo…”. Ricordo Estrella, che mi ammutolì domandandomi un semplice “possiamo aiutarla in qualche modo, professore?…”. Ricordo Sarita, una ragazza bruttina ma con occhi di un blu liquido che parevano pennellati da Van Gogh ad Arles, che tentò di farsi promettere “una volta terminato il viaggio passerà a trovarci per mostrarci qualche foto?”, alla quale goffamente spiegai che forse non avrei potuto nemmeno terminare il viaggio, e che controbattè ridendo “e no, le foto ce le fa vedere, sotto al bar, così ci evita una lezione!”.
“Però a un certo momento invertii il gioco. Volli fare io una domanda, ovvero cosa avessero da dirmi, cosa pensavano di ciò che avevo appena confessato, cosa gli passava per la mente. E che potevano rispondere liberamente.
“Fu una slavina!
“Ricorro al mio taccuino per non confondere le cose più belle che abbia sentito dichiararmi in tutta la mia vita. Vediamo… Estrella mi consigliò di non badare alle stagioni, che vanno bene tutte per qualunque cosa. Diego si raccomandò di buttare gli occhi addosso a qualunque donna mi capitasse a tiro, di qualunque età colore di capelli della pelle degli occhi credo religioso politico calcistico, tranne il Real Madrid o una franchista, e che se proprio mi fossi trovato a dover selezionare, che fosse il Real Madrid e non la franchista!
“Risata fragorosa.
“Jordi mi disse di non abbottonare la camicia fino al collo, non più, neppure col vento o la pioggia, e di prendermela tutta, senza ombrello, che rompe i coglioni è vero, ma è una delle cose più belle del mondo, poi Miguel mi propose di scattare ogni giorno una fotografia nel posto che mi sembrava più bello, ovunque mi trovassi, fosse anche al chiuso, di non saltare un giorno… Soledad, con quel sorriso invincibile dei vent’anni mi disse di dimenticarmi di tutto e di viaggiare leggero, di portarmi appresso solo due paia di mutande, un maglione, un paio di scarpe e uno di stivali, niente k-way, nessuna pastiglia, nessun rimorso, e di prendere a ricordare soltanto il presente, giorno dopo giorno, di perdermi per strada, che il mondo là fuori ha tanta voglia di giocare, e noi sempre così seri… Invece Ines mi disse di non dimenticarmi di loro, che alla fine non tutto vale allo stesso modo, è vero, ma tutti valgono qualcosa… Antonio si raccomandò di dormire poco e stare sveglio più possibile, di portarmi appresso un block-notes e segnarmi le cose viste e i pensieri fatti, magari facendo qualche schizzo, perché no, anche se c’è da dire che io non so tenere una matita in mano… Guadalupe poi, dal suo letto di sogni a occhi aperti mi consigliò di imparare ad amare anche chi mi sembrava non meritarlo, feci per interromperla, mi sembrava una cazzata, ma mi rimbrottò che è un peso insopportabile quello di non averlo fatto, anche se alla fine si piange ogni giorno per qualcuno che se ne va, anche se anche se anche se… Jorge disse che così, su due piedi, non gli veniva in mente nulla, ma che se avessi scritto la mia mail sulla lavagna mi avrebbe mandato un suggerimento entro due o tre giorni… Esteban si raccomandò di starmene via il più possibile, non per loro, ovviamente, ma per me, che più me ne sto in giro più le cellule si dimenticano di essere impazzite, che è la solita catena a fare male, la solita strada le solite facce tutti i giorni, lo stesso trattenersi dal mandare affanculo chi vorremmo mandarcelo… Ilona mi guardò e mi sorrise, dall’alto dei suoi voti più bassi di tutta la mia carriera, e mi ricordò di quando arrivai in classe col gesso a un braccio, anni prima, e lei si mise a ridere, e quando le chiesi che cosa avesse da ridere mi rispose che le piaceva pensare che per almeno un mese non avrei scritto stronzate alla lavagna, e io la spedii dal preside che la sospese per una settimana, allora quando si ricompose da quella risata mi disse che non ce l’aveva con me quella volta, che non le era mai passato per la testa, ma che quando seppe di dover restare fuori da scuola una settimana non potè che ringraziarmi, le avevo fatto il favore più grande degli ultimi tre anni di scuola… Ursulina mi ricordò di un libro che avevo consigliato alla classe tempo prima, ‘La polvere del mondo’ di Nicolas Bouvier, uno dei più bei libri di viaggio che conosca. Lo aveva letto solo lei, devo dire, e in quel testo c’era scritto che ‘il fuori guarisce’, fu Ursulina a ricordarmi la frase, e aggiunse che se viaggiando fossi stato bene… bè, che esigenza c’era di tornare?… Invece Moreno mi consigliò di prendere a indossare le camicie sul davanti, come fossero un càmice, e farmele abbottonare dietro, di parlare con gli scoiattoli e di ululare alla luna, durante il viaggio cercare posti lontano dalle luci delle città per ricominciare a guardare le stelle, che non ci facciamo caso ma sono grappoli fittissimi, e di spalancare le finestre in piena notte per ascoltare il velluto del silenzio, la conversazione delle cicale, o l’amore incondizionato dei grilli per le tenebre, di lasciar raffreddare le pietanze prima di mangiarle, e di scaldare la pancia se fa male, di respirare con cognizione, di smettere di stirare che tanto i vestiti vivendo si stropicciano, di imparare altre lingue, di portarmi appresso uno strumento musicale, anche piccolo, e di suonare, anche senza pubblico o al buio, ma di suonare, che fa bene, di sedermi di schiena in riva al mare, in silenzio, e fare l’esercizio di contare le onde ascoltandone lo scroscio, ma di evitare di contare la sabbia che è più complicato, di dimenticare le abitudini, e di ridere, di ridere pure senza scherzare, di ricamare una parola, di non avercela con il mondo e neppure con il tempo, e di smetterla di avercela soprattutto con me stesso, di abbassare la voce per ascoltarci parlare, e di alzarla quando qualcosa ci fa male, di farmi abbracciare dalle farfalle Monarca del Messico, anche se andavo in Asia, di non fiatare di meravigliarmi ancora di vergognarmi soltanto di una cosa, di non avere vissuto, e disse che un bambino non può morire in riva al mare, ritmando le parole con la punta della matita battuta sul banco Moreno mi disse queste cose e altre, mi spiegò che se ha fatto male una volta farà male ancora, ma che se ha funzionato una volta, pure quello funzionerà ancora, che a suo modo di vedere la lunghezza non incide sul cammino, come il demerito non incide sull’amore, e che se avessi avuto voglia di parlare a qualcuno ma in quel momento mi fossi trovato solo, di parlare a voce alta, e mentre la classe uno sguardo dopo l’altro si volse a lui stupita commossa e preoccupata, disse ancora una cosa o due, di non spegnere una candela solo perché non mi serve più la luce, ma di lasciarla fare, per conto suo, fino alla fine, e terminò spiegando che quelle erano le cose che avrebbe voluto dire a suo padre prima che morisse, tre anni prima, ma non ci era riuscito, perché… non sapeva perché, e che la vita è una cosa strana, tante sono la pazienza e la vergogna che ti rovescia addosso ogni giorno… e poi Julio… in prima fila, l’ultimo a intervenire ma senza parlare, Julio guardò tutti facendo un disegno a ventaglio con lo sguardo, poi guardò me, poi di nuovo la classe, in silenzio, poi guardò la sua mano destra, che teneva chiusa a pugno, così che quando rialzò lo sguardo e incontrò il mio fece per aprire le cinque dita tendendo il braccio, in modo che nessun altro lo vedesse, e mi spiattellò a un metro dagli occhi il palmo ora completamente aperto, dove stava scritto a pennarello nero, chissà da quando: TE QUIERO INES
“Ti hanno fottuto, professore!
“Molte settimane dopo quell’ultima mattinata in classe, mi trovavo in Kashmir, pronto per ripartire alla volta del Tibet. In Kashmir, come per tutta la durata del viaggio, avevo modo di accedere a Internet ogni qualche giorno. Una delle ultime sere, poco dopo il tramonto, feci richiesta per usufruire del computer da tavolo di proprietà della locanda nella quale avevo trovato alloggio per tre notti, e potei connettermi qualche minuto, il tempo necessario a scaricare la posta, ed eventualmente rispondere. Ma insomma… io di solito quando sono in rete apro Google Maps, oppure cerco informazioni relative al viaggio, alle sistemazioni, o articoli di storia inerenti i luoghi che di volta in volta raggiungo. Tutto lì. Quella sera invece, fra le mail ne trovai una di un mio allievo, uno di coloro che avevano parlato in aula prima della mia partenza, Moreno, sì insomma, quello delle farfalle del Messico in Asia… Diceva:
“Buongiorno professor Torres Medina, sono Moreno Armando Rubio Sanz, si ricorda immagino. Non ho idea di dove si trovi lei in questo momento, suppongo in Asia, in Pakistan o in Tibet, non so, in ogni caso lungo il fiume Indo. Chissà come sta? So che mi sto intromettendo nelle sue cose e nel suo cammino, sarà qualcosa di indimenticabile immagino, non è vero? E so anche che il suo indirizzo mail non l’ha lasciato agli studenti, ma io sono riuscito ad averlo tramite la presidenza della scuola. Gli ho parlato, sanno di cosa si tratta, e alla fine hanno acconsentito a passarmelo, facendosi garantire che non l’avrei diffuso ad alcuno. E infatti, glielo assicuro, così sarà.
“Professor Torres Medina, è successa una cosa molto brutta che mi riguarda. Il problema è che se gliela racconto senza spiegarle ciò che vi sta prima, gli antefatti insomma, sarebbe ancora più complicata da comprendere. Spero di non portarle via troppo tempo, piuttosto si stampi questo messaggio, se ha modo, e se lo legga in un altro momento. Oddio!, sapesse quanto mi dispiace disturbarla in un periodo della sua vita così particolare, durante un viaggio così bello e così importante…
“Si ricorda di mio padre, vero professor Torres? Mio padre morì tre anni fa per un cancro al sistema linfatico, fu un calvario molto lungo, nonostante periodi alterni di semi-benessere, se posso dire così. In ogni caso, molti degli ultimi mesi di vita li trascorse in ospedale. I miei genitori erano giovani, concepirono me e mia sorella Pilar Nerea, di due anni più piccola di me, molto presto. Mia madre, Florencia Natividad, aveva due fratelli più anziani, ora non so ma mi pare di almeno sei o sette anni. Uno fa il falegname, l’altro è un poliziotto, sta sempre in ufficio però, non lavora in pattugliamento. Sono miei zii, ma li ho sempre frequentati poco, il poliziotto poi mi è sempre stato antipatico, con quella faccia da sbruffone, e il falegname, anche lui, non mi pare chissà che persona. Sta di fatto che una sera di alcuni anni fa, quando avrò avuto su per giù nove o dieci anni, in casa, oltre a mia madre c’era lo zio poliziotto, che allora non faceva ancora il poliziotto, era venuto a trovarla, e li sentii litigare molto male, nel senso che urlavano come dei pazzi. Mio padre non c’era, era al lavoro. Sentii che lo zio disse a mamma, a un certo punto, una cosa come ‘e vedi di non raccontare nulla ad Antonio, ci siamo capiti, sorellina streghetta?!…’ Antonio sarebbe mio padre, professor Torres, cioè… era mio padre. La cosa si chiuse lì, più o meno. Nel senso che mi successe altre volte di sentirli litigare furiosamente, e non so se accadesse anche quando io ero fuori casa o a scuola. Comunque sia, ogni volta che mi capitò di assistere a scene del genere, anche se ero nella mia stanza e più che altro li sentivo ma non li vedevo, mio padre non c’era, mai. Quando poi, anni dopo, venne ricoverato la prima volta a causa della malattia, anzi, per la precisione una decina di giorni dopo il ricovero, un pomeriggio al rientro da suola trovai mia madre in lacrime, in cucina. La sentii dall’ingresso, appena chiusa la porta di casa. Mi fermai un istante pensando fosse la televisione, invece quando arrivai sulla porta della cucina la vidi seduta al tavolo, con una gamba tirata su e appoggiata alla seduta della sedia di fianco, un gomito appoggiato sulla tovaglia, e la testa china, sulla mano a conca, era disperata. Mi avvicinai, si accorse di colpo che ero rientrato, evidentemente non mi aveva sentito. Per lo spavento fece un balzo all’indietro sollevando il mento, e le dissi Mamma, sono io!… E lei si scusò… si scusò e alzandosi mi abbracciò. Professor Torres, è difficile da spiegare, ma quell’abbraccio di mia madre non lo dimenticherò neppure quando saranno morti i mei pronipoti, e i figli legittimi e illegittimi dei miei pronipoti. Sembrava che il mondo dipendesse da me, pareva che la nostra vita fosse aggrappata a quell’abbraccio. Io non sapevo cosa fare. Ricambiai l’abbraccio, chiaramente, e la strinsi forte, perché anche se della mamma a quell’età mi cominciavo a stufare, capii che c’era qualcosa che non andava e… non so, professore, e io ero l’unica persona a cui lei si stava appoggiando. Mi sentii un poco più uomo, ma malamente, ero impacciato e impaurito, perché agli uomini come sa le parole non escono mai quando dovrebbero uscire. Mia sorella di solito rientrava a casa prima di me, ma quel giorno era andata da una compagna, me lo disse mia madre stessa, e capii più tardi, intendo giorni più tardi, che l’aveva convinta lei. Non riuscii a capire che cosa fosse successo. E’ chiaro che i miei pensieri andavano a mio padre, cioè al fatto che stava male, che era in ospedale, che aveva una brutta patologia, e che ci avevano detto, anche a noi figli, che non ci sarebbero state molte speranze. Credetti che l’incubo, l’unico incubo di mia madre fosse quello, del resto era anche il nostro. Era la cosa più naturale del mondo, oltretutto i miei genitori sono sempre stati innamorati persi l’una dell’altro, professore, lo sa? Voglio dire, lo so che sarebbe ovvio che fosse così, se si sta insieme, si hanno dei figli, si cresce tutti sotto lo stesso tetto, l’amore è lì che dovrebbe stare, no? Ma io so già da molto tempo, anche se non ho nemmeno vent’anni, che è abbastanza raro che sia così. Mi basta osservare, oppure ascoltare le storie di molti miei amici o compagni di scuola per sapere che matrimonio figli e amore si sposano male. Invece mia mamma e mio papà sembravano due ragazzini, sempre, si tenevano la mano quando erano per la strada, anche quando c’eravamo io e mia sorella, la sera a tavola chiacchieravano guardandosi negli occhi come degli adolescenti, cioè come dovrei fare io con qualche ragazza ma non è che mi capiti tanto spesso, e si immergevano talmente l’una nello sguardo dell’altro che Pilar e io potevamo organizzare qualunque cosa a quella tavola, weekend, serate, scorribande, rapine a mano armata, che loro manco si accorgevano che eravamo a cena con loro! Ah dimenticavo… pensi che a ogni compleanno di mamma, mio padre arrivava con un pacco col fiocco, e un biglietto per il teatro o per un concerto. E ogni volta, dopo cena, si sedevano sul divano, con la televisione che si sgolava a vuoto, e mamma apriva la sorpresa, le si illuminava il volto, e a quel punto ci dicevano di andare in camera nostra o di andare a fare un giro con gli amici e spegnevano la luce… Io ho imparato i suoni dell’amore da loro. Si portavano la bottiglia di vino e i bicchieri dalla tavola al divano, li appoggiavano sul pavimento, e buonanotte ai sognatori! Ecco perché pensavo che la disperazione di mia madre fosse dovuta esclusivamente alla malattia di mio padre e alla sua pena. E invece c’era dell’altro, ma io ancora non lo capivo.
“La prima volta che successe in mia presenza, mentre rientravo da una serata con amici, non capii del tutto come erano andate le cose. Avevo acceso la luce dell’ingresso, e vidi, cinque secondi dopo, mio zio poliziotto uscire dal bagno, con le maniche della camicia sbottonate e stropicciate, i pantaloni di jeans con la cintura slacciata, e senza scarpe. Aveva il viso ancora inumidito, come quando ti lavi e passi l’asciugamano di fretta perché sei in ritardo. Incrociai il suo sguardo e ricordo che rimasi zitto, stupìto, più che stupìto spaventato. Lui invece, con tutta l’ovvietà del mondo mi sorrise appena, e mi disse una cosa talmente naturale che la ricordo ancora, nonostante siano passati anni, per la precisione tre anni e tre mesi, mi disse Stai vicino a mamma in questo periodo, ne ha bisogno, mi raccomando sia a te che a Pilar… Mi parve tutto strano, strano che fosse lì a casa nostra a quell’ora, strana quella camicia trasandata, strana la cintura dei pantaloni slacciata, ma quello che disse non potei che condividerlo. Feci un cenno di assenso con la testa e andai in camera mia. Non riuscii ad ascoltare cosa si dissero con mia madre, anche se cercai di tendere l’orecchio. Mia sorella non c’era, era dalla sua amica Guadalupe, così mi spiegò mamma quando mio zio se n’era andato da un po’. Il problema è che quando andai in cucina, dopo aver sentito la porta d’ingresso chiudersi dietro mio zio, la trovai nuovamente disperata, come quel giorno al rientro da scuola. Indossava una specie di vestaglia bianca che metteva quando andava a dormire, faceva un contrasto molto bello coi lunghi capelli neri che aveva. Mi abbracciò nuovamente, e questa volta feci tutta la fatica del mondo ma alla fine riuscii a chiederle Che c’è, mamma?… La sentii sospirare e sbattere il suo petto contro il mio prima di rispondermi Papà sta male, e io non so cosa fare, non so come faremo, Moreno, è tutta la mia vita papà… e si mise a singhiozzare disperatamente, come se tutto fosse già finito, come se papà fosse già morto, come se tutti fossimo già all’inferno. Presi coraggio, e dopo minuti interminabili, quando mi accorsi che cominciava a calmarsi, le chiesi che ci facesse lo zio a casa nostra a quell’ora. Non parlò per qualche secondo, poi mi guardò dritto negli occhi e mi disse di non dire nulla a nessuno, che ci stava aiutando, che passava di tanto in tano per chiacchierare un po’. Magari dopo cena, magari nella tarda mattinata, a seconda degli orari o dei turni al lavoro. Faceva compagnia, si parlava, l’ascoltava mentre lei si sfogava. Non risposi, feci un cenno con la testa. Ma perché non avrei dovuto dire niente a nessuno se stava aiutandola? E perché quella sera lo zio aveva un’aria come se fosse a casa sua e si fosse appena alzato dal letto?
“La volta successiva fu di sabato. Al pomeriggio ero andato con mamma e Pilar in ospedale a trovare papà. La situazione era stabile, si parlava di dimetterlo, temporaneamente, entro tre o quattro giorni, se fosse rimasto in quelle condizioni. Certo, era questione di poco tempo, ma stare a casa con tua moglie e i tuoi figli è tutta un’altra cosa che stare in un ospedale. La sera uscii con Manuel, un vecchio amico, e, come previsto, dopo saremmo andati a dormire a casa sua, i suoi erano via per il fine settimana. Era un’abitudine abbastanza costante in quel periodo. Fuori di casa i suoi, dentro noi! Una volta da Manuel però, era già quasi mezzanotte, mi resi conto di aver dimenticato da me il pigiama, ma soprattutto i giochi della Playstation, entrambe le cose infilate nello zaino che in settimana usavo -e uso ancora- per la scuola. Del pigiama, ovviamente, non me ne fregava nulla, ma dei giochi sì! Abitavamo vicini, lui e io, e senza pensarci su dissi Dieci minuti e sono qua! Così mi avviai a casa di corsa. Arrivando al portone pensai che mamma fosse a letto, o stesse guardando la televisione, in quel periodo era talmente nervosa che prendeva sonno tardi e passava molto tempo davanti alla TV prima di addormentarsi. Così pensai di entrare tentando di non farmi sentire, per non svegliarla se tesse dormendo. Pilar invece non so dove fosse, a casa o da Guadalupe, oppure con Paco, un ragazzino con più brufoli che anni che da qualche mese vedevo spesso con lei. Infilai la chiave nella serratura e feci girare due volte, prima di sentire il minuscolo scatto che fa la porta mentre si apre. Strano, perché quando mamma sapeva che non doveva entrare o uscire più nessuno, di sera, dava sempre quattro giri, ma non ci badai. La televisione in cucina era accesa, a volume basso, come sempre la sera. Mi fiondai in camera e afferrai lo zaino. Volevo tentare di non farmi notare, in modo da tirarmi dietro la porta con tutta la cautela possibile e andarmene senza che lei se ne accorgesse, altrimenti magari mi avrebbe fatto la ramanzina perché girare per la strada a quell’ora è pericoloso… Il fatto è che quando ripassai in ingresso sentii come delle grida strozzate, e pensai nuovamente alla TV. Poi le risentii di nuovo, ed erano chiaramente oltre il volume della televisione. Mi bloccai nell’ingresso al buio, e stavolta udii una voce di uomo ma bassa, quasi un sibilo, quello di chi vuole zittire qualcuno ma lo fa metà urlando metà trattenendosi, e la voce diceva Puttana, sta zitta!, hai capito?!, hai capito che devi stare zitta?!… eppure le grida strozzate proseguivano. Allora mi avvicinai alla porta della cucina, era accostata ma non chiusa, e con una paura fottuta tentai di sporgere soltanto il naso e un occhio. A parte la TV accesa non c’era nessuno. Così pensai di avvicinarmi alla camera da letto. Anche lì la porta era accostata, ed era strano, perché quando mamma era sola o anche quando era con papà ma non stavano facendo l’amore, quella porta era sempre aperta, anche di notte. Mi avvicinai più terrorizzato di prima, le grida continuavano, provenivano proprio da lì. Avevo la tachicardia, lo zaino in spalla sembrava tirasse il torace per staccarmelo, sentivo vampate di calore in faccia. Quando fui accanto alla porta mi feci coraggio e, come prima, infilai la testa in camera. La luce al soffitto era spenta ma quella sul comodino dalla parte di mamma, il lato più distante dalla porta, era accesa. C’era mio zio, il poliziotto, completamente nudo sopra la mamma, che aveva una specie di fazzoletto bianco legato alla bocca, e la picchiava mentre ne abusava come un animale impazzito. Mi sembrò di svenire. Vidi un braccio di quello schifo d’uomo sollevarsi e la mano colpire mia madre in testa, con un suono sordo e ripugnante. Cazzo, cosa dovevo fare?!… A un tratto lo vidi sollevarsi e gli vidi il pene uscire da in mezzo alle cosce di mamma, per non vomitare mi misi a urlare come un dannato Ma che cazzo fai, bastardo!… Si può sapere che cazzo fai?!… E corsi verso di lui urlando Figlio di puttana bastardo merda di uomo che cazzo stai facendo?!… Mia madre si liberò del fazzoletto perché lui a quel punto era con una gamba e un piede sul pavimento, e l’altra gamba sul letto, in piedi ma in bilico. Gli afferrai un braccio e lo tirai verso me, tentando di fargli perdere l’equilibrio e di farlo cadere, solo che mentre cadeva rovinò addosso a me. Mamma a quel punto si mise a urlare Moreno! Moreno! Stai attento Moreno, stai attento, cosa fai?!… Ero sul pavimento, supino, con quell’animale lurido dello zio sopra di me. Non fosse che mi faceva ribrezzo come ogni parte di lui, gli avrei preso l’uccello e glielo avrei strappato a morsi, a quel figlio di quella puttana della madre di lui e di mia madre e di quell’altro falegname di merda! Pensai che mi avrebbe colpito a morte, ormai non riuscivo più a muovermi, ero completamente schiacciato dal suo peso, il mio corpo era di un terzo più piccolo e più leggero del suo, e poi lui, anche se io avevo la forza della rabbia ceca addosso, era pur sempre un poliziotto, e anche se non lavorava in pattuglia sarà stato pur sempre addestrato a far male alle persone, del resto che cazzo devono fare per portare la pagnotta a casa, quei maiali? Invece no. Non mi colpì. Non mi ammazzò. Non mi diede nemmeno una sculacciata. Si sollevò in piedi, guardandomi come si guarda un paralitico -magari si stava guardando allo specchio!- e con un mezzo sorrisino in faccia allungò la mano e prese la mia. Non sapevo cosa fare, avevo il fiatone, la sua testa di merda si era appena sollevata dal mio petto e stavo riprendendo a respirare. Mi strattonò fino a che riuscì a tirarmi in piedi. A quel punto mia madre mi raggiunse e mi abbracciò, tutta sudata, con un ematoma vicino all’orecchio sinistro, e i seni e le cosce semi-illuminati dalla luce tiepida della abat-jour sul comodino, luce che la ricalcava, a disegno, attraverso il sudore. Sentivo l’odore dello zio nella melma di quell’abbraccio, e sentivo il calore dolcissimo e mortuario delle lacrime di mamma che mi scendevano sul collo, a rivolo lento, come una processione. A quel punto udii la voce del non-uomo, quasi rammendata, come un vestito stropicciato stiracchiato alla bell’e meglio, che diceva Tu non hai visto niente, ok?… La mamma aveva solo bisogno di distrarsi un po’… Ora io me ne vado e lei ti spiegherà con calma come stanno le cose. Stai tranquillo, tutto si sistemerà. E’ già tardi, domattina mentre voi dormite noi si lavora, io sono di turno. Mentre diceva quelle porcherie, che solo più tardi scoprii essere ancora più violente di quegli schiaffi e di quel pene che usciva dal corpo di mia madre, si stava rivestendo. Non oltre cinque minuti più tardi era fuori casa.
“E fu allora che compresi cosa sia la violenza. Ovvero quando mia madre, seduta sul letto con me accanto, sfiorita in una notte di tutta la sua bianca e giovane bellezza, mi disse che non avrei potuto far nulla, non avrei potuto parlarne con nessuno, sarebbe successo un pandemonio, nessuno avrebbe creduto a un ragazzo, e anche se qualcuno mi avesse creduto, lo zio aveva conoscenze che io, la mamma, Pilar o papà non avevamo. E poi, in nessun caso a papà doveva giungere la notizia di quelle violenze, sarebbe stato immondo, sarebbe morto prima della condanna stessa che portava sulla testa. La guardavo con pena e con rabbia, la guardavo negli occhi e le guardavo l’umido luccichìo sulla pelle, le guardavo le cosce nude e i seni piangere rivoli di sudore, e non capivo. Non capivo nulla. Le dissi soltanto una cosa, prima di correre fuori e mettermi a camminare per una Salamanca notturna e nauseabonda. Le dissi Ma è tuo fratello…
“Pochi giorni dopo, come sperato, mio padre venne dimesso per qualche tempo. Da quel sabato notte in poi mi fu sempre più complicato mantenere quel “segreto” con papà. Magari con gli altri facevo meno fatica, ma con papà mi pareva uno strazio. Al tempo stesso sapevo che lo strazio più atroce sarebbe stato che lui potesse sapere. E’ che mio padre, fra le altre, mi aveva sempre insegnato una cosa particolare, da quando ero bambino, e me la insegnava nell’unico modo in cui si possono spiegare le cose a un figlio, cioè comportandosi come le parole che diceva. E questa cosa era dire la verità. Che sembra difficile, sembra la strada più complicata, ma è l’esatto opposto di tutto questo. C’è da passare alcuni brutti quarti d’ora, a volte, a causa della verità, così mi diceva quando se ne parlava, ma poi tutto fila più liscio. Magari non tutti i problemi si risolvono, ma possiamo permetterci di stare faccia a faccia con qualcun altro a carte scoperte. E ora io mentivo. A lui. Che stava giocando pulito. Giocava duro e maledetto, ma pulito. Noi no.
“Poi anche quei giorni passarono, e papà rientrò in ospedale. Per molto tempo, ogni qualche settimana di ospedale, lo mandavano a casa tre o quattro giorni. Io cominciai a perdere peso e a perdere le parole, a scuola, come ricorderà professore, intervenivo sempre meno, con gli amici non uscivo quasi più, anche se a dire il vero ero sempre più spesso in giro, perché casa mi faceva paura, mi faceva schifo rimanerci. Camminavo da solo per Salamanca, tutto lì. Con mamma non sapevo come comportarmi, la vedevo sfiorire per la questione di mio padre e distruggersi per la questione di mio zio, ma se provavo a dirle di reagire, di fare saltare il tappo e mettersi a raccontare tutto, a chiunque, entrava in una disperazione ancora maggiore. Aveva gli occhi incavati, sembravano marmo, sembravano già morti.
“Fino a che mio padre entrò in coma. Ci chiamarono dall’ospedale una sera tardi, corremmo fin là. La situazione era critica. Tutto quanto, tutti gli anni che aveva vissuto, amato, insegnato, lottato, stavano appesi a una cordicina talmente sottile che a guardarla anche solo a un metro di distanza non la si vedeva neppure. E poi morì. Una mattina all’alba. Di fianco a lui c’era mia madre. Pilar ed io eravamo a casa a dormire. E’ da allora che penso come uno stupido a cosa possono essersi detti, col pensiero, mamma e papà in quelle ore. Quali dicerie, quali sofferenze, quali paure, che sentimento diverso da quello dell’amore dei tempi nei quali aprivano i regali sul divano, o quale sentimento invece medesimo, potrebbe essere professore, no? A volte, chissà… a volte magari l’amore ritorna possente, diafano, levigato come la pelle del mare dopo che le onde hanno fatto tutto quello che dovevano fare, a volte l’acqua torna alla sua forma felice, come la natura, come gli alberi, dopo che è passata la tempesta, non è vero? Magari anche senza aspettare che la tempesta sia passata, potrebbero esserci angoli di mare o di foresta nei quali tutto per un istante si placa, prima di riprendere il combattimento, e noi che ne sappiamo? Chissà, professore, che cosa possono essersi detti, col pensiero e con le mani, mentre tutto intorno a loro cedeva, si imputridiva, invecchiava e crollava… Cosa si dice quando si muore? Magari Ti amo? Magari Ti amo, sì… magari Ti voglio bene, Antonio… magari Ti voglio bene, Florencia… magari durante quelle ore la sacralità della morte potrebbe aver redento la sconsacrazione della vita, il dolore osceno e selvaggio che un essere umano non dovrebbe arrivare a provare e invece prova, magari un giorno la memoria del mondo li restituirà alle cose…
“Avrei voluto dirgli anch’io delle parole, quelle che non fui mai capace di dirgli perché stavo mentendo, da settimane, da mesi stavo mentendo, e non riuscivo a dire, non riuscivo a parlargli, non riuscivo… Così le dissi a lei, professore, quelle cose. In classe, ricorda? Quando ci disse della malattia e della sua partenza imminente per l’Asia. In realtà avevo immaginato di pronunciare quei pensieri almeno durante la messa per il funerale, ma non ci riuscii nemmeno lì. E naturalmente al funerale partecipò anche lo zio.
“Il tempo trascorso da allora, da tutti quegli avvenimenti a questa mail con la quale la sto disturbando, è trascorso come un lampo.
“Poi la settimana scorsa è successo. Tornavo verso casa a piedi, arrivavo da Avenida Federico Anaya e avevo appena superato prima la rotonda di Plaza Castilla y Leon e subito dopo la rotonda Glorieta Julio Robles, ed ero entrato su Calle Rafeal Lapesa, dove si trova il Centro Sportivo Multiuso Sánchez Paraíso. La nostra casa si trova al fondo della via, e guardando in quella direzione da inizio strada, cioè dove mi trovavo in quel momento, la prospettiva, col sole contro, certe sere al tramonto è molto bella, pur essendo una comune strada di casette residenziali a due piani. Da qualche minuto avevo notato delle camionette dei vigili del fuoco sfrecciarmi accanto, già in Avenida Federico Anaya. Sirene, luci blu, e fra un camion e l’altro anche un paio di macchine della polizia e un’ambulanza. Ero più incuriosito che altro. Fino a che, appena superato il Centro Sportivo non sollevai lo sguardo e notai, al fondo della nostra strada, fiamme altissime propagarsi dalle finestre e dal tetto di un’abitazione verso il fondo della via. Erano le otto di sera e c’era ancora una buona luce, ma il cielo era già di quel blu cupo del dopo tramonto, così che le fiamme pareva lo squarciassero insieme all’orizzonte. Diventavano a loro volta un palazzo sempre più alto, giallo rosso arancione, c’era vento quel giorno, e le alimentava in maniera furibonda. Pensai a qualche abitazione prima della nostra, e affrettai il passo. Al passaggio dell’ennesima camionetta dei pompieri che mi restituì una folata d’aria che mi fece sobbalzare, mi misi a correre. Aumentavo la velocità ogni due passi, sentivo salirmi dentro la paura. Più mi avvicinavo più il palazzo di fiamme e vento diventava mastodontico. Si era preso tutto quanto l’orizzonte, lo sguardo non riusciva a vedere altro che muri e pilastri e vampate che ondeggiavano come bocche oscene. Cominciavo a sentire in gola l’odore acre e denso dell’incendio e delle cose che bruciavano. A un tratto mi resi conto che i palazzi di fianco sembravano spariti, tutto dava l’idea d’essere avvolto dal fuoco, e che questo divorasse anche la campagna attorno e una gigantesca fetta di cielo. Mi si parava innanzi solo più luce gialla e rossa, e sentivo alitarmi in faccia vento rovente. Era casa nostra. Che mentre ero giunto a meno di due isolati da essa si afflosciò con un rumore sordo, il primo piano venne inghiottito dal piano terra, che scompariva a mano a mano che le fiamme se lo divoravano, come i bordi di un foglio di carta a cui diamo fuoco, che scompare lasciando acceso e poi nero il perimetro che ne rimane. Mi fermai. Volevo chiedere ai pompieri cosa fosse successo, se c’era qualcuno dentro casa, e chi. Sapevo che mamma e Pilar potevano essere lì ad aspettarmi per cena, ma non so in base a quale speranza illogica immaginai che non fosse così, no di certo. I pompieri urlavano fra loro e correvano da una parte e dall’altra, nel frattempo uno di essi venne a recintare la strada. Mentre mi dimenavo e sentivo l’orrore mangiarmi lo stomaco e la pelle e mi grattavo i vestiti e la faccia e mi pisciavo addosso, sentii un tonfo orribile, impressionante. Mi voltai e mi accorsi che l’ultima lastra di tetto era crollata su quel che restava del piano terra, sollevando una nuvola violenta di fumo, dalla quale non feci in tempo a ripararmi, e che dovetti respirare, almeno in parte, anche se avevo istintivamente portato le mani alla bocca. E svenni.
“Ripresi conoscenza in ambulanza. Vedevo una donna e un uomo attorno a me, mi guardavano dall’alto in basso, dietro di loro il tettuccio e di fianco a loro la flebo, che non capivo se fosse per me, perché non sentivo pungere o dolore al braccio. Probabilmente domandai qualcosa ma non ricordo cosa, so solo che la donna fece un lieve sorriso e mi disse di non preoccuparmi, avevo battuto la testa cadendo, ma non era nulla di grave. Improvvisamente rividi quelle fiamme e pensai a mia madre e a mia sorella, e scoppiai a piangere, violentemente. La donna e l’uomo tentarono di calmarmi, mi chiesero se avessi male da qualche parte, ma non riuscivo più a parlare, vedevo soltanto il tetto che crollava e la parete esterna della casa che si sbriciolava assieme alla mia anima di ragazzo che avrebbe voluto essere quello che è e null’altro, un ragazzo. In ospedale stetti fino al giorno seguente, per precauzione. Al mattino, dopo una nottata d’angoscia infernale arrivò la polizia per interrogarmi. E fu lì che mi dissero ciò che continuavo a immaginare dalle otto della sera prima. Sia mia sorella Pilar che mia madre Florencia erano morte nell’incendio. Però dovetti attendere altri due giorni, professore, per sapere cosa fosse successo.
“Mia madre aveva approfittato di uno dei soliti pisolini che mia sorella faceva nel tardo pomeriggio, soprattutto in questo periodo, quindi aveva chiuso a chiave la porta della sua camera e tutte le finestre di casa. A quel punto aveva acceso il gas della cucina. Vigili del fuoco e polizia hanno rinvenuto anche una tanica di benzina, e delle tracce di carburante su ciò che restava del pavimento e dei muri. Evidentemente nella follia della disperazione era stata precisa fino all’insopportabile, voleva essere completamente sicura che le fiamme cancellassero cose carne e dolore. Una volta cosparsa la casa di benzina e sentita la puzza di gas saturare ogni alito, doveva aver acceso tre o quattro fiammiferi contemporaneamente, pare ne abbiano rinvenute alcune microscopiche parti, e non è detto, evidentemente, che a quel punto avesse fatto in tempo a gettarli sul pavimento bagnato di benzina, dato che la prima fiammata potrebbe averla divorata all’istante. Il resto è ciò cui ho assistito dalla strada. I corpi non sono stati rinvenuti se non a ciocche e brandelli, come zolle di carbone sotto la cenere.
“Mia madre Florencia Natividad e mia sorella Pilar Nerea sono state cancellate dal fuoco di un inferno pagano dopo anni di stupri e violenze ripetuti e raccapriccianti, perpetrati da quel non-uomo che è mio zio e lo zio di mia sorella, fratello di mia madre. Io ora non ho nulla più. Da meno di quattro giorni vivo, almeno temporaneamente, proprio in casa loro, dei miei zii, il poliziotto e la di lui moglie, di entrambi non cito nomi e cognomi, perché per me non ne posseggono, almeno su questa terra che appartiene all’ingiustizia, certo, ma in egual misura alla dignità. Mi hanno “destinato” qui gli altri componenti della famiglia, del resto vivono tutti lontano da Salamanca. Presto m’inventerò qualcosa e andrò via.
“Le scrivo, professor Torres, pur sapendo che quello che sto per chiederle è una cosa che non le compete, e che al tempo stesso non vorrei chiederle affatto. Lei è in Asia per qualcosa di ben più importante della giovinezza sgangherata di un suo ex allievo. Mi rivolgo a lei soltanto perché non ho alcun altro cui parlare sinceramente, con il cuore pulito e onesto. Domani comincerà il terzo girone del mio inferno personale, dopo quello della malattia e della morte di mio padre, e quello delle violenze perpetrate e tenute ignominiosamente nascoste di mio zio su mia madre e su mia sorella. Ma questo sarà un inferno che mi porterà fuori dalle fiamme, all’aria aperta. Costerà tempo lotta dolore umiliazione e infinita pazienza, ma questa volta il fine sarà un da capo. Domani andrò alla polizia a denunciare mio zio. Un loro collega in carriera. Lo farò da solo, evidentemente, perché da solo io sono.
“Mi ascolti, professor Torres, ce l’ha insegnato lei ad ammetterlo: ho bisogno di aiuto.
“Tutto qui.
“Non torni a Salamanca per me, ma la prego di prestare attenzione fino in fondo mentre le dico questa cosa con tutta l’onestà di cui sono capace: io sono un ragazzo. Un ragazzo. E volevo soltanto essere tale, fino a che fosse venuto il tempo di divenire altro. E quella gioventù da domani la andrò a cercare e a riprendere, a costo di tutti i costi che avrà.
“Me la sa dire una cosa? Che cos’è la vita, professore?’
“Segue la firma del professore: Joaquin Roldan Torres Medina”
Le tazze vuote dei due caffè americani erano affiancate al lato della mano di Luz che reggeva i fogli, a loro volta affiancate a quelle precedenti, non si toccavano per una manciata di millimetri. Il Cafè de la Barra era un impasto di luce giallognola e vociare indefinito. Dal vetro accanto al tavolino si constatava ormai certa l’alba, anche se il sole da dietro la cordigliera non era spuntato ancora. Nell’ultima ora si erano alternate piccole scosse brevi ad altre altrettante piccole ma più durature, senza però allarmare la piccola folla che nel frattempo sfaldava. Antares voltava lo sguardo con lentezza attorno a sè, ma ogni volta che i suoi occhi tornavano al tavolino si posavano esclusivamente sui fogli ancora aperti fra le mani di Luz, fogli che sembrava stessero sfiatando, e che lei tardava a ripiegare. Luz invece lo guardava dritto in faccia Antares, e sapeva che quel piccolo peso lui l’avrebbe percepito. Quando finalmente sollevò lo sguardo a sostenere le lampare negli occhi della donna, vi fu un istante di silenzio smarrito. Dopodiché disse
“Mi pare di capire che non conosceva da prima quell’uomo…”
“A quanto pare, gli incontri inattesi sanno dispiegare le nostre rivelazioni. Feci conoscenza col professor Torres Medina al tavolo di quella caffetteria di Salamanca. I fatti risalgono agli ultimi dieci anni, con una buona dose di approssimazione”
“E’ in contatto con lui?”
“Il giorno seguente tornai a Salamanca, da sola. Gli avevo chiesto di rivederci, acconsentì, e alla fine mi consegnò una copia di questo scritto così particolare”
“Perché le raccontò la storia, secondo lei? E perché le consegnò lo scritto?”
“Perché mi raccontò la storia? Non ne ho idea, e non glielo domandai. Per caso, dovrei dirle. Fu sufficiente il fatto d’essere seduti a due tavoli affiancati, e di avere entrambi in mano una birra, anche se mi pare poco… Ma lo scritto glielo chiesi io il giorno seguente, dopo esserci parlati. Perché io non lo sapevo d’essere parte di quel viaggio, Antares. Come Kalindi non sapeva d’essere parte di quello di Manuel. Moreno Armando Rubio Sanz è il ragazzo con cui feci l’amore per un’intera settimana dopo l’aborto del mio secondo figlio, qui a Santiago. Si trattava sicuramente del periodo successivo alla decisione di sporgere denuncia a causa delle violenze a sua madre e a sua sorella. Le persone con cui viaggiava erano la famiglia di un suo caro amico, che si erano fatti carico di tenerlo lontano, per qualche tempo, dall’incubo nel quale si trovava, prima che cominciasse il processo, approfittando di un bel viaggio e di una vacanza che loro avrebbero fatto comunque. Ho saputo tutto questo in quel pomeriggio di Salamanca, pochi mesi dopo esserci detti addio, Moreno ed io. Se ho ripensato a lui, mi domandava prima che le leggessi lo scritto del professor Torres Medina. Antares, cos’è che vuole sapere, cristo santo? Io ogni giorno penso a Iguazù, all’alveo fluviale e al sapore virginale di quel boato mostruoso e redentore, ogni giorno penso al dio al quale non ho mai creduto ma che mi manca, all’ocra sulle case di Mompox aggrappate al Rìo Magdalena, ogni giorno m’invento un fiore inesistente, che conosco soltanto io, e lo dono a mio padre e a mia madre com’erano allora, lo poso sulla tavola della cucina, di fianco a dove piangevano abbracciati ascoltando la voce di Allende prima di morire, ogni giorno il presente mi pare più impenetrabile e sputato a una puttana da quattro soldi, eppure lo attendo sfinita come si aspetta l’alba dopo gl’incubi delle tenebre, ogni giorno io sono il mare e la barca e la tempesta, ogni giorno sono la voce rauca dei bevitori che pregano rasente i muri, ogni giorno penso che chi giudica è senz’altro colpevole, ogni giorno pronuncio tra me e me almeno una parola in una lingua astrusa, ogni giorno ho pensieri che divengono fontane che zampillano e carillon che suonano boleri, ogni giorno spalanco una finestra e posso vedere le parole di Thomas Sankara, ascoltare i suburbis di Mompou, osservare chiunque senza giudicare o farmi cantare nuda da un pittore, ogni giorno penso che ciascuno di noi sperimenta la propria egira e fugge alla propria Medina, ogni giorno, mio caro, siamo tutto ciò che siamo e anche ciò che ci manca, ché a suon di tradimenti ho compreso che non sono i tradimenti a farti male, ma il mancato appuntamento con quella che avresti voluta essere, ed è proprio qui che giorno dopo giorno sto cercando di non arrivare, a volte quando non mi vede nessuno provo un passo di danza sulla musica delle mie contraddizioni, perché so di essere qualcosa di meraviglioso e tragico, eppure ogni giorno ho più voglia di ricominciare che di finire, perché so che da qualche parte qualcuno colleziona afriche e qualcuno americhe, e i treni che ci dovrebbero portar via non lo faranno solamente perché non vi siamo saliti, e se non vi siamo saliti ci deve essere una stilla di perché, da qualche parte, forse in uno di questi giorni, forse nelle nostre collezioni di scuse, dunque la risposta è sì, cazzo, penso a Moreno ogni giorno, ogni giorno… perché ha ragione Kalindi, è tutto insieme, in un un unico momento, il nostro tempo.
“Come vede, vivo di dubbi, e più ancora ne muoio. Ma uno è il più subdolo: cos’è questa corrente sotterranea che muove in direzione contraria alla nostra marea, alla nostra remata, ai nostri desideri, obbligandoci a percorrere cento passi, per progredire di uno? Chi è che la governa? Me lo dica: siamo noi, vero?
“Ho perso ogni uomo della mia vita, Antares. A monte, nei miei letti, e a valle. Li ho visti scorrere, ma non mi hanno abitata. Mio padre, i miei amanti, i miei figli. Conosco i loro nomi ma non ne posseggo una storia, eccetto ceneri o brandelli di abiti mai indossati. E’ come se fossi scivolata sopra la mia stessa vita, anziché esserne il cuore. Siamo il padre che ci manca, siamo quel paese là, il diritto di possederlo e il dolore d’averlo creduto. Lo conosceremo attraverso il riempimento di un’assenza, il canto a brandelli e a volte struggente di una semplice, sporca e fallace memoria. Sembra il più mancante dei ruoli, quello del padre, pare esprimersi per sottrazione, o come il negativo per una fotografia, che anche quando fosse stampata, lui non sarebbe comunque qui, con noi.
“Eppure, se aveva ragione Holderlin, è giustappunto verso la casa di nostro padre che torniamo sempre, ma che crede Antares, siamo goffi e arrabbiati, e scappiamo, solo che il mondo è rotondo, e non facciamo altro che la strada più lunga per arrivare, come che sia, là. Però si deve tentare la svolta, mollare il perno attorno cui giriamo in tondo, e andare oltre, incamminarci fuori. Chissà, forse scriverò una lettera, a mio padre, e quest’oggi la lascerò sotto al suo nome inciso su quel muro, prima di ripartire. Perché anche lui sappia della mia vita. In fin dei conti, ciò che ci manca di nostro padre, è ciò che ci manca di noi. Forse noi siamo nostro padre.
La cordigliera non celava più il sole, i cui primi ricami, da qualche minuto, avevano raggiunto i profili di Luz e di Antares, così come il tavolino che li divideva, facendo apparire tazze e cucchiaini come residui di un altro tempo, ed imbastendo nuovi fugaci giochi nelle iridi di Luz.
“Perché si sceglie un testimone, Antares? Perché ci sceglie, il testimone?”
Luz Inocencia Santana Carrasco pronunciò queste ultime parole scostando la sedia e alzandosi. Afferrò la borsa nera e volse lo sguardo, guardingo, oltre il vetro del bistrot. Era ormai giorno pieno. Antares la osservò per un breve istante, ancora non l’aveva vista in piedi. E la immaginò fare l’amore guardando i libri di suo padre. Dopodiché anche lui si sollevò, fece due passi per porgere i soldi in cassa, e raggiunse Luz, ch’era già sul marciapiede di José Miguel de la Barra. Respirarono la pelle di polvere e terrore di Santiago, e si volsero un’ultima volta lo sguardo. Infine Antares le domandò
“Luz, le posso chiedere il perché dell’altra sua scelta? Cambiare vita a ogni terremoto.”
“Cosa le devo dire Antares, forse è solo un modo per non dover morire di una vita sola…”
Interno notte – Fine
|49828 battute spazi inclusi – 8569 parole|
Donazione
Lettura e downloads gratis dall’inizio alla fine! Dopo di che, se pensi che questo esperimento di apertura e di condivisione libera meriti un incoraggiamento, una pacca sulla spalla, puoi usare il bottone qui sotto ? per mandarmi qualche moneta (o quel che credi). Non per “pagare” lettura e download, che (come vedi) sono gratis, ma come sostegno per il piccolo sbattimento che c’è dietro la preparazione di tutto l’ambaradan e soprattutto per il progetto. Non è nemmeno necessario avere un conto PayPal, basta una carta di credito, anche ricaricabile. Se scegli di fare una donazione, ovviamente la cifra la decidi tu, ma tieni conto che €3 sono già più di quanto ricaverei da ogni copia cartacea venduta. Tuttavia, se inavvertitamente ti scappasse il ditino sui numeri, io corro a leggerti il libro in soggiorno!… ?????