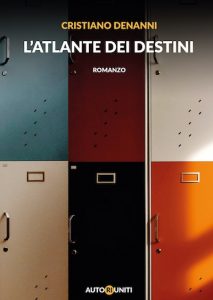“Il bene prevale numericamente sul male, ma non sa fiutare il pericolo” (da ‘Maschere per un massacro’, di Paolo Rumiz)
Come si prepara un viaggio a Srebrenica?
La verità è che non programmai il mio viaggio in Bosnia Erzegovina (che organizzai invece all’ultimo momento) facendo caso alle date, ma arrivai proprio l’11 luglio (2017), che per quella terra è una data tragicamente fondamentale. Nelle ore fra il 10 e il 12 luglio del 1995 infatti (24 anni fa), a Srebrenica, cittadina a poco più di 100 chilometri da Sarajevo, le milizie serbo-bosniache agli ordini del generale Ratko Mladić, nell’ambito di un atto di vera e propria “pulizia etnica“, eseguirono quello che gli stessi tribunali internazionali definirono un genocidio, il più impressionante e buio massacro accaduto in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 8372 musulmani di sesso maschile e in età compresa fra i 15 e i 65 anni furono sterminati (a volte con fucilazione a volte con sistemi ancor più abominevoli) e sepolti in fosse comuni. Più volte gli stessi corpi furono spostati da un punto ad un altro nel tentativo di occultare i fatti e le prove. Il 13 luglio, quindi poche ore dopo, altri 300 musulmani, che avevano trovato “riparo” a Potočari, paese nei pressi di Srebrenica, presso il compound dei Caschi Blu olandesi della Nato, subirono la stessa sorte. I Caschi Blu li allontanarono dalla base e serrarono i cancelli, asserendo che non vi era più spazio sufficiente e che comunque non vi era alcun pericolo. Dei fatti di Srebrenica l’opinione pubblica seppe molto tardi, e spesso molto male. Come del resto a proposito delle stesse guerre “dietro casa nostra” in ex Jugoslavia. È del 27 giugno 2017 una sentenza di secondo grado della Corte d’Appello dell’Aja che conferma il verdetto del primo grado, e condanna lo stato olandese della responsabilità dei 300 morti di Potočari. È un verdetto a metà, secondo molti, se non addirittura blando, ma ugualmente importante, perché pone un primo punto giuridicamente ufficiale sulle estese, contorte e a volte criminali responsabilità di quella che a volte in errore chiamiamo “diplomazia internazionale”.

Cose che non riesco a dimenticare.
Ci sono tre immagini, fra le tante, che mi hanno sempre fatto provare un moto di rabbia e di profonda angoscia (termini comunque inefficaci di fronte all’abominio della storia).
La prima è questa: è l’11 luglio, un filmato di una qualche televisione che sta intervistando Mladić. Il generale parla a dei bambini, gli regala delle caramelle, e assicura che i loro padri (musulmani) sono al sicuro, non gli verrà torto un capello, presto torneranno da loro. Mentre parla, a pochi metri da lì, il massacro ha già avuto inizio, e i padri di quei bambini vengono sterminati in quello stesso momento.
La seconda immagine è una fotografia, pubblica: è il 12 luglio 1995, quindi il giorno nel quale sono accaduti i fatti di Srebrenica e il giorno prima di quelli di Potočari. Si vede il generale serbo-bosniaco Ratko Mladić (a sinistra) bere con il comandante del contingente olandese dei caschi blu, colonnello Thom Karremans (al centro). Chiaramente entrambi in abiti militari. Uno è lì a sterminare, l’altro sarebbe lì a porre una qualche forma di difesa, in nome dell’Europa. Europa che nel 2012 riceve il premio Nobel per la Pace perché “ha contribuito all’avanzamento della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa” (dal testo sulla motivazione del premio). Mladić e Karremans bevono assieme.

Ma Karremans di fatto lasciò la base dei Caschi Blu nelle mani di Mladić, quindi permise ai militari serbi di procedere alla deportazione forzata di uomini bosniaci dalla città di Srebrenica a Potočari, divenuto poi da luogo di protezione per i musulmani a teatro di un massacro. Nel momento in cui Mladić lo accusò di avere richiesto il bombardamento da parte delle forze Nato, Karremans si difende pronunciando una frase che molti ricordano con indignazione: “Io sono solo il pianista. Non sparate al pianista“. Esiste un video che riprende la scena. Mentre nel momento in cui Karremans lascia la base di Potočari, Mladić gli consegna una lampada da tavolo come regalo per la moglie (Karremans attraversava in quel periodo una crisi coniugale, uno dei tanti motivi per cui il suo diretto superiore, generale Hans Couzy, dichiarò in più di un’occasione che Karremans non era adatto a fronteggiare una situazione come quella di Srebrenica).
La terza immagine è rappresentata dalla figura della figlia femmina di Mladić: Ana. Ana Mladić si tolse la vita con un colpo di pistola la notte del 24 marzo 1994. Per molti versi il gesto (di per sé insondabile) del suicidio rimane un mistero irrisolto, anche se probabilmente Ana, dopo avere scoperto che la “stella” che rappresentava il padre per lei e per la sua vita era una fandonia, cadde in uno stato di angoscia e prostrazione indicibili. Durante e dopo un viaggio post laurea (in medicina) a Mosca assieme ad alcuni amici, molti dei quali bosniaci musulmani, lontana dalle “censure” che la avvolgevano in Serbia, Ana conobbe passo passo “la verità”. A questo va aggiunto un ultimo orribile fatto: il soldato Dragan Stojkovic, l’uomo che l’amava e con cui aveva una relazione, osteggiata dal padre Ratko, venne mandato a morire al fronte da quest’ultimo. Dalla vicenda di Ana Mladić prende le mosse un libro importante e (a mio parere) straordinario, “La figlia”, di Clara Usòn, edito in Italia da Sellerio, e del quale riporterò alcuni dati al fondo di questo articolo, fra i ringraziamenti e la bibliografia.
Nel 2010 Hasan Nuhanovic, l’interprete che assistette Karremans e Mladić nelle trattative, e i familiari dell’elettricista Rizo Mustafić, in forza al Dutchbat, denunciarono Karremans e due dei suoi collaboratori per genocidio e crimini di guerra, accusandoli di aver consegnato i loro familiari ai Serbi. In tutti i processi nei quali è stato chiamato in causa, prima come testimone (Tribunale per i Crimini dell Ex-Jugoslavia a Den Haag) e poi come imputato, Karremans ha sempre negato di aver saputo che i musulmani abbandonati a Srebrenica fossero destinati al massacro. Va detto che il “Tribunale penale internazionale per l’Ex-Yugoslavia” non poté incriminare Karremans in quanto di nazionalità olandese e non balcanica.
Dopo tre anni di indagini, il Pubblico Ministero dichiarò i tre militari non perseguibili.
Ma questo è un “mondo alla rovescia”, come diceva Eduardo Galeano, e così nel 2006, Karremans e tutti gli uomini del Dutchbatt non solo non vennero mai condannati, ma ricevettero una medaglia a riconoscimento delle avversità affrontate!
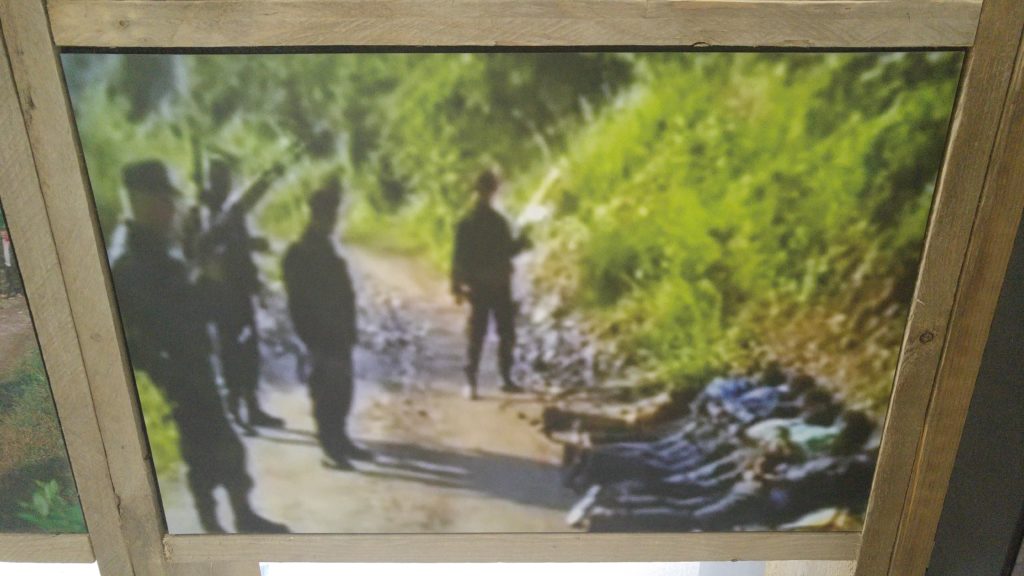
Sentenza e condanna.
Ci vollero 22 anni e 4 mesi (di cui 15 di latitanza), da quel 11 luglio 1995, ma il 22 novembre 2017 Ratko Mladić, il macellaio del più grande genocidio avvenuto in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato condannato all’ergastolo dal Tribunale penale internazionale, ufficialmente colpevole di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, per aver avuto un ruolo da protagonista in un’associazione criminale con lo scopo di eliminare la popolazione non serba dalla Bosnia, per operazioni sanguinose di pulizia etnica, responsabilità in stupri e stupri di massa, stermini, e per aver avuto un ruolo decisivo nel bombardamento d’artiglieria effettuato dalle forze serbe di Bosnia, contro la capitale bosniaca Sarajevo, nei mesi di assedio che portarono alla morte di diecimila civili.
Delle guerre in ex Jugoslavia e in particolare di Srebrenica non si può certo parlare diffusamente qui, soprattutto è necessario fornire informazioni e dati ulteriori. Cosa che tento di fare al fondo di questo testo, ma lo farò soprattutto indicando testi, autori, articoli, romanzi, monologhi teatrali. Non ho, del resto, alcuna altra autorità in merito. Naturalmente citerò anche chi, direttamente o indirettamente, mi aiutò prima durante e dopo quel viaggio fra le dolci bellezze e le ombre storiche di quei luoghi.
Perché parlare di Srebrenica, oggi?
Volli vedere, fotografare, e, quando possibile, pubblicare della bellezza di quella terra, ma è importante conoscere le storie e la Storia che ci stanno dietro. Non si comprende solo attraverso il buio, neppure solo attraverso la luce. Molte volte il gesto dolce di una donna o di un uomo sono gentili perché sono passati attraverso montagne di dolore. Perché parlare di Srebrenica, allora, se questo non è il luogo più indicato? Me lo chiesi allora e me lo chiedo ora. Perché è necessario. Sempre e comunque. Perché sovente è di chi ci sta più vicino, nello spazio e nel tempo, che sappiamo meno. E non è giusto, umanamente e “storicamente”. Sono passati 24 anni. E non tutte le persone massacrate a Srebrenica sono state ritrovate, non tutte sono state identificate, molti non hanno ancora un nome. In quei giorni di luglio del 2017, al memoriale di Srebrenica, mentre guardavo i filmati in cui il generale Mladić passava caramelle ai bambini e gli diceva di stare tranquilli, feci fatica a capire che cosa dovevo pensare, che cosa potevo pensare.

Come si può “guardare” il dolore? Come fotografarlo?
Trascorrere una giornata a Srebrenica ti fa pensare ad alcune cose, probabilmente poche ma a ripetizione, e ti fa sentire. Quello sì, soprattutto sentire. Cosa, è difficile dirlo. Una sorta di tentativo di vicinanza. Forse non ai fatti ma all’uomo. A quale? In che modo? Mi tornarono alla mente alcune parole di Primo Levi, quando alla domanda di una giornalista Rai, attorno alla metà degli anni ’80, a proposito di quale fosse l’uomo cui si riferiva quando scrisse le righe a mo’ di dedica che portano il titolo al libro Se questo è un uomo. Allo sterminatore o allo sterminato? Rispose, con quella voce precisa e gentile, che pensava ad entrambi. È questo un uomo, colui che finisce e muore, dentro ai campi, nelle camere a gas, nella tortura, nella cancellazione della propria identità? È questo un uomo, colui che pianifica una fine, colui che progetta sterminio, che disegna realtà su basi etniche, religiose, genetiche, e su queste premesse permette e si permette l’indicibile? Su bambini, su donne, su uomini, su ogni zolla d’essere umano. Non sapevo se andare a Srebrenica, anche se sapevo di volerlo. Perché mi sentivo fuori luogo. Perché non sapevo come “stare”. Come essere Cristiano Denanni. Non trovai e non ho trovato risposte, evidentemente. Ma mentre vagavo e fotografavo nell’hangar della vecchia fabbrica abbandonata di fronte al memoriale e al cimitero, dove ora si trova il museo della vergogna, costituito di fotografie, filmati, audio, mappe, oggetti, successe una cosa, come fosse scattato un interruttore, una cosa piccolissima. Stavo per uscire dall’hangar, avevo fotografato molto, scattavo alle stesse foto esposte in questa scenografia post-bellica e post-industriale, tentando di ritrarle nel contesto marcio anch’esso, quando, già sulla porta d’uscita, entrò una scolaresca. Saranno stati una quarantina di ragazze e ragazzi.

Cominciavano il loro giro. Ciascuno “se la vedeva” senza intermediari, da solo. D’istinto l’ingenuità, o forse la stupidità che mi contraddistinguono, mi fecero pensare che magari fra loro -qualcuno di loro- si formerà l’anticorpo in grado di scansare l’aria, perché no con una bella risata, le prossime volte che qualcuno userà parole come “razza”, o “nazionalismo”, o “popolo eletto”, o “predestinazione alla sconfitta”, o che ci vorrà convincere ad aver paura delle ultime ruote del carro anziché delle prime.
Poi mi fermai un istante a osservarli da dietro, quei ragazzi, mentre guardavano fotografie e leggevano documenti. E senza pensarci un attimo mi venne voglia di seguirli e fotografarli, a loro volta, mentre si ponevano, ciascuno a modo proprio, di fronte alla Storia, a quella -questa- precisa storia, di vent’anni fa o poco più, accaduta dietro casa nostra. Con la complicità ripugnante dell’Olanda, della Nato, dei Caschi Blu, delle Nazioni Unite, e di una buona fetta di questa Europa.

Così, dopo le fotografie, i pensieri e i sentimenti al memoriale e al cimitero, dopo una passeggiata sulla statale, in un tutto permeato di sole e silenzio, dopo aver osservato dalla strada il compound gestito dai Caschi Blu dove avrebbero dovuto trovare riparo bambini donne e uomini, tentai una possibile elaborazione, non certo finale, e neppure unica, tantomeno risolutiva (di cosa?).
Seguivo e osservavo i ragazzi guardare la Storia, dove quella storia non ha ancora, neanche, finito di accadere. Ogni anno infatti si ritrovano corpi, nella boscaglia e all’interno di fosse comuni, e vengono seppelliti, dopo aver tentato di identificarli. Li scorgevo un poco di nascosto, e fotografandoli mi chiedevo qual è il punto in cui il passato riesce a divenire quel presente che sono, che siamo. Perché solamente in quel momento, lungo ma finito, ciò che verrà potrebbe svoltare. Potremo svoltare. Improbabile. Ma non impossibile.
Eccola, la galleria di immagini di quella giornata a Srebrenica: davanti al dolore del mondo
Ringraziamenti
Ci sono dei ringraziamenti che desidero fare, relativi al mio breve ma intenso viaggio in Bosnia Erzegovina del 2017. Riconoscenze dirette e indirette, per questioni pratiche oppure di riferimento ideale o culturale che sia, di cui ho potuto usufruire prima durante e dopo il viaggio. E quindi grazie:
-a Donatella Sasso, dell’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, presso il Polo del ‘900, a Torino. Grazie per la chiacchierata in Istituto prima della partenza, per i rispettivi ricordi di Luca Rastello, e per i consigli su Sarajevo e le impressioni su Srebrenica, per i tuoi articoli sul Genocidio e sul negazionismo che hai voluto inviarmi.
-a Roberta Biagiarelli, attrice ed autrice, assieme a Giovanna Giovannozzi e a Simona Gonella, di un testo sul genocidio dal titolo “A come Srebrenica“, che consiglio sicuramente a chiunque volesse approfondire. Grazie della disponibilità.
-a Vedran Jusufbegovic, la mia guida “personale” a Sarajevo. L’ho già ringraziato sui miei account social, ma lo rifaccio molto volentieri. Per la preparazione, le curiosità svelate, i ricordi vivi, la grande umanità e la simpatia.
-a Mustafa Demirovic, la mia guida “personale” (un’altra?…ebbene sì) a Mostar. Per le affinità di pensiero, la bellissima chiacchierata, pur breve, e per la condivisione di una certa visione, magari poco accomodante e un po’ amara ma urgente. E, non ultima, per la grandissima simpatia. Grazie “Vecchio Sciamano Pazzo Nevrotico e Ansioso”!
Bibliografia e fonti varie
Ci sono poi i libri, importantissimi, che mi hanno aiutato ad aprirmi un varco nella confusa e troppo manipolata memoria dei fatti, pur così recenti e a noi vicini. In ordine sparso:
–Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia, di Paolo Rumiz, ed. Feltrinelli. Breve ma illuminante, e disincantato, sguardo generale (ma nemmeno tanto) sulle guerre in ex Jugoslavia e le loro premesse, molto meno balcaniche e più europee di quanto si pensi, all’insorgere di qualcosa che fino a una manciata di anni prima non sarebbe potuto apparire possibile alla grande maggioranza delle persone. Bellissime, dolci e accalorate, in particolare, alcune pagine su Sarajevo, la sua laicità, la sua profonda bellezza, la sua tenacia. “Il bene prevale numericamente sul male, ma non sa fiutare il pericolo” (Rumiz)
–La guerra in casa, di Luca Rastello, ed. Einaudi. Capitoli ciascuno su di un episodio, una storia personale, una testimonianza, sempre seguiti da un “inserimento” nella Storia più generale legata a quei fatti. E poi un affresco, inedito, poco noto, struggente e “giusto”, sul legame stretto, e in buona parte istintivo e non programmato, fra Torino e la guerra “dietro casa”. L’accoglienza dei profughi in famiglie, nata da slanci sempre individuali e mai istituzionali, le sofferenze, le condivisioni, le confessioni. Un testo preciso, atroce, quanto amorevole. Il capitolo sulla cronologia dei fatti di Srebrenica riduce al lumino molte nostre convinzioni morali.
–Diario di Zlata, di Zlata Filipovic, ed. BUR. Una testimonianza, una bambina che racconta Sarajevo sotto le bombe. Ha 11 anni, Zlata, nel 1991, a Sarajevo. E tiene un diario. Dei suoi giorni. Quei giorni..
–La figlia, di Clara Usòn, ed. Sellerio. È un romanzo, ma di profonda -e precisa- radice storica. La protagonista è Ana Mladic, figlia del generale serbo Ratko Mladic, uno dei responsabili della “pulizia etnica” verso i musulmani e il carnefice di Srebrenica (11 e 12 luglio 1995). Ana è un’anima ostinatamente, e forse ciecamente, innocente. Suo padre è, in famiglia, il suo “angioletto”, la sua ala protettrice, il suo riferimento. Scoprirà, in una serie di vicende personali, lentamente, amaramente, la verità. Ana venne ritrovata morta il 24 marzo 1994 a Belgrado, per suicidio. Si ritiene che alla base del gesto estremo vi sia la sconvolgente “perdita dell’innocenza” seguita al disvelamento del “vero” padre e, come se non bastasse, la scoperta che la morte del suo compagno, in guerra, sia stata diretta volontà dello stesso Mladic. Un romanzo potente, che miscela la impressionante mole di dati storici della ricercatrice, al pathos della letteratura. Per fornirci più insonnia che addomesticamento.
-I siti web East Journal e Osservatorio Balcani e Causaso Transeuropa.
E poi, idealmente ma solo per modo di dire, ci sono alcuni scritti, alcuni articoli, alcune lettere di Susan Sontag, su questa (su quella?) guerra. La Sontag Sarajevo la visse profondamente, per non poco tempo, diceva che spesso ci si sentiva più a suo agio che a New York. Le voleva bene, a Sarajevo (difficile, in effetti, immaginare di poter provare un sentimento diverso). Le sue parole sui fatti della ex Jugoslavia erano attente, partecipate, acute, sofferenti, e a volte, intellettualmente, e forse anche sentimentalmente, scomode, affatto ordinarie, difficili da mandar giù, eppure importanti. La Sontag era una di quelle donne che anche quando non ero d’accordo con lei (raro), la capivo perfettamente. Anche se faceva male.