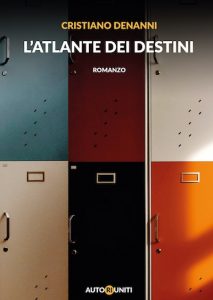Una retrospettiva su Werner Bischof di qualche tempo fa a Torino, mi ha permesso di fare alcune considerazioni, ma soprattutto di trarre degli insegnamenti, non soltanto fotografici, che mi va di condividere con chi ha voglia di leggermi.
Come dicevo, nulla di inedito a proposito dei suoi lavori. Ho avuto invece l’occasione per ripercorrere la storia di un uomo. Bischof è considerato da tempo, anzi da sempre, un animo “gentile” fra i mostri sacri dell’agenzia Magnum. E per il suo carattere, certo, ma anche perché rispetto ai padri fondatori dell’agenzia, come Cartier-Bresson e Robert Capa egli ha sempre avuto un approccio meno da “reporter” e forse più da osservatore, però mai passivo sia chiaro.

Mi sono commosso percorrendo la sua così veloce parabola. E’ morto a soli 38 anni. Io li avevo pochi anni fa 38 anni e… c’è da imparare insomma. Per quanto del tempo, dicendola con Santiago Gamboa, non si diventi esperti. Ribadisco, non sto parlando del fotografo Werner Bischof e finita lì. Se sei soltanto un fotografo e non un uomo, o soltanto un panettiere e non un uomo, o soltanto un amministratore delegato e non un uomo, spiace dirlo, non sei nulla. Lui cominciò, come spesso accade, con fotografia da studio, moda, nudi, oggetti, geometrie perfette.
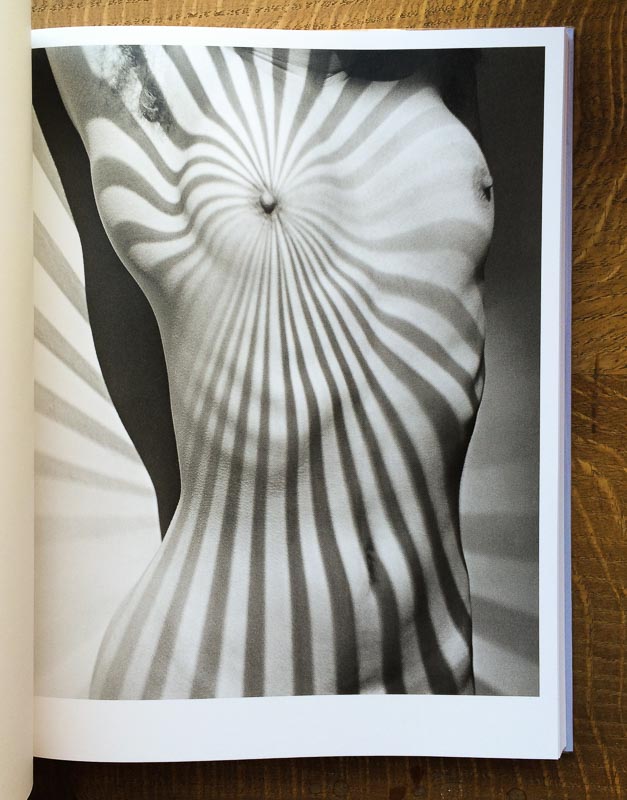
Finita la seconda guerra mondiale, qualcosa cambiò, anche in lui. Prese la bicicletta e decise di girare il sud della Germania a “documentare” le rovine, i resti, le macerie, ma soprattutto gli umori. Dice:
“Poi arrivò la guerra, e con essa la distruzione della mia ‘torre d’avorio’. Da quel momento in poi la mia attenzione si concentrò sul volto dell’essere umano che soffre… Volevo comprendere quale fosse il volto vero del mondo”.
Non voglio farla lunga, la sua storia basta leggerla su di un libro o sul web.
Perché mi ha commosso, insomma? Perché osservando il disegno del suo percorso sul mondo ho sentito tutta la sofferenza, la fragilità, la imponente bellezza di un essere umano che vuole diventare più di un professionista del nulla, più di uno spettatore passivo -come si diceva-, ma un testimone della propria epoca. Nel senso più alto del termine. Del termine testimone, intendo.

Lavorò per Life e altre memorabili testate, ma più d’una volta manifestò la sua stanchezza, la sua rabbia nello scorgere soltanto giochi di potere dietro la disperazione e la feroce bellezza del mondo che di anno in anno attraversava. Dall’India un giorno, siamo nel 1951, alla moglie scrisse:
“Certo, mia carissima, c’è tanta bellezza, danze nei templi del sud di un fascino irreale… oggi però mi trovo all’inferno, con tutto quello che ne consegue. Non scapperò dal diavolo, perché è parte della nostra esistenza… sono un osservatore nel mattatoio della bellezza”.
‘Un osservatore nel mattatoio della bellezza’, cazzo! Ma ci siamo capiti?… Mezzo mondo o forse più, insomma. Poi lo mandarono in Indocina e quello fu l’ultimo lavoro commissionato. Dopo di allora decise di mollare la “routine” del cacciatore obbligato di storie. Cercò dei finanziatori, ci volle tempo, ma poi ce la fece e partì per il Sud America.
“Sono stufo di non far nulla e non vedo l’ora di partire per il Sud America. E’ l’unico posto che mi interessi…” (da una lettera a Robert Capa – 11 maggio 1953).
L’anno seguente, dopo aver cominciato un lavoro interamente suo fra genti, popolazioni, tradizioni di paesi a sud del Messico, scattò quella che è forse la sua fotografia più “famosa”, il bambino che suona il flauto camminando su di una montagna andina, lungo la strada per Cuzco. Fu l’ultimo scatto. Proprio in quei giorni, e precisamente il 16 maggio del 1954 lui e due suoi collaboratori a bordo di un’auto persero il controllo e volarono giù da un burrone. Nove giorni dopo dall’altra parte del mondo morirà l’amico e collega della Magnum Robert Capa, saltando su una mina, a sud-est di Hanoi.

Perché mi ha commosso, continuo a pensare? Perché un uomo ha bisogno di fare molta fatica per diventare un uomo. Perché per diventarlo bisogna volerlo fortemente. Non basta nascere, voglio dire. Perché quale che sia il tuo mestiere il tuo strumento la tua arte, se ne hai una, a un certo punto senti il bisogno di far parte della tua epoca in modo più intimo e viscerale, senti il bisogno non soltanto di sfilargli accanto ma di appartenere all’essere umano. E di raccontarlo, di proteggerlo, di denunciarlo. E questo, soprattutto se sei “gentile”, ti costerà una vita intera. Un giorno scrisse al padre, era il 1948:
“Quello che non capisci è che non faccio questi viaggi per bramosia di emozioni ma perché voglio intraprendere un cambiamento radicale come essere umano… Non riesco più a fotografare belle scarpe, oggetti di lusso, bicchieri spumeggianti o cose del genere… Mi sono liberato dalle briglie dell’appagamento personale e adesso appartengo alla gente – non a un individuo ma all’umanità”.
?Iscriviti a “Biscuter“, il mio canale Telegram!?
- Tags:
- Storie